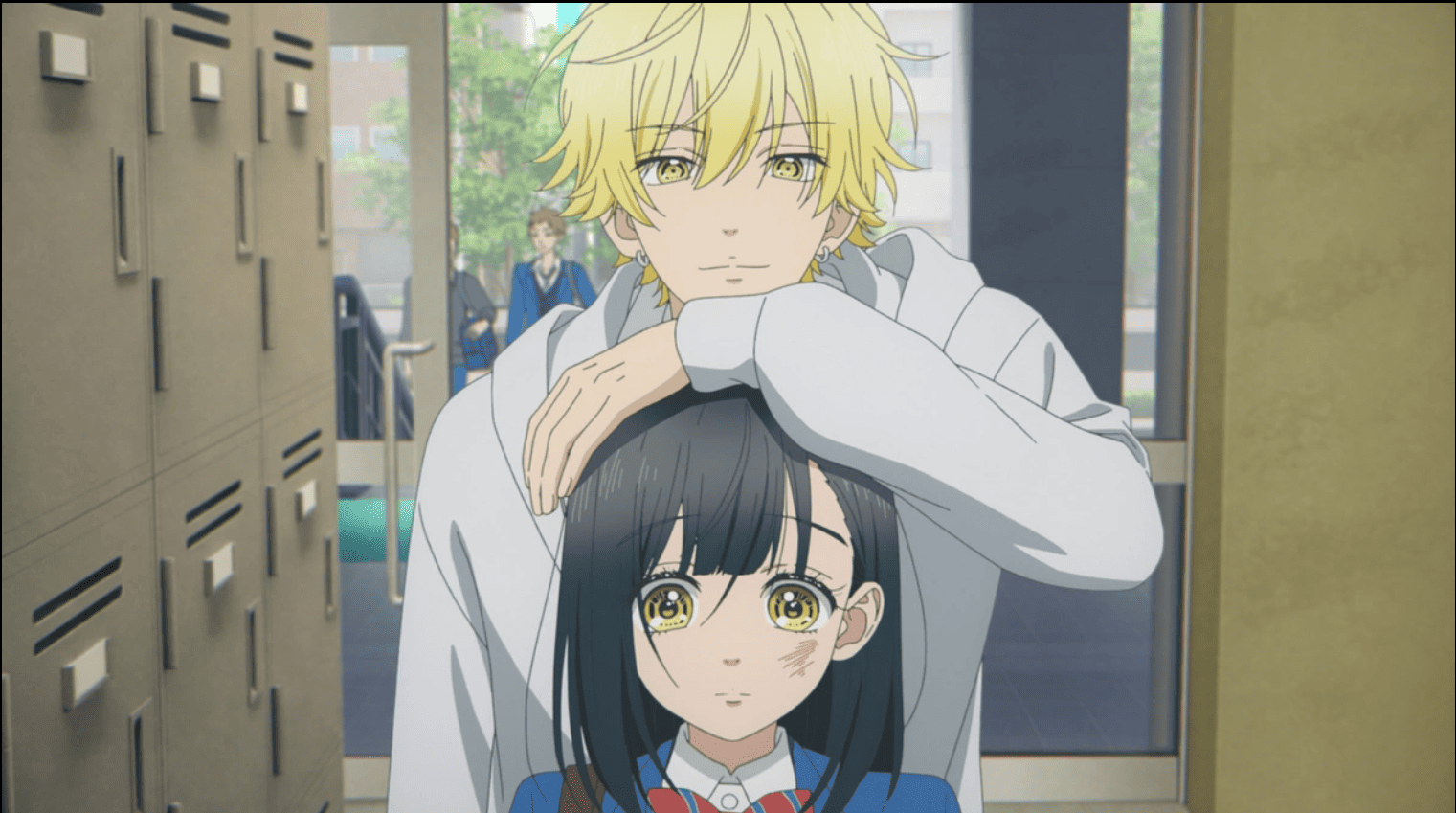Uka Ishimori e Kei Miura sono spesso comparsi nei feed dei miei social durante i passati mesi invernali. Ovviamente, non avevo idea che si chiamassero così ma il titolo dell’anime di cui sono protagonisti ha iniziato a imprimersi nella mia testa insieme all’idea di dare un’occhiata – prima o poi – ai 12 episodi della prima stagione presenti su Chruncyroll.
Il momento propizio è arrivato con le vacanze pasquali. Avendo finalmente un po’ di tempo a disposizione, mi sono decisa a premere il tasto “play” incoraggiata anche dai tanti commenti positivi che mi era capitato di leggere su Internet. È così che, in poco più di 24 ore, sono entrata nella storia di Honey Lemon Soda -sparkling love story. O, almeno, nella sua prima parte.
Nonostante non ne sia rimasta folgorata, mentirei se dicessi che la visione non è stata interessante o coinvolgente. Honey Lemon Soda è carino, intrattiene in maniera piacevole spettatori e spettatrici e vanta alcuni aspetti interessanti. Personalmente, trovo il sottotitolo – sparkling love story – poco adatto a rappresentare la natura dell’anime. Non c’è nulla di “frizzante” nella storia raccontata. Almeno non per il senso che io attribuisco all’aggettivo. Potrei definire sparkling le dinamiche relazionali presenti in Romantic Killer o The apothecary diaries, ma non quelle di Honey Lemon Soda. Per quest’ultimo è molto più adatta l’immagine del miele evocata dal titolo vero e proprio. La mancanza di effervescenza, infatti, è compensata da una buona dose di dolcezza che non si può fare a meno di provare di fronte a certe scene.
Storia d’amore tra i banchi di scuola
Uka Ishimori ha trascorso gli anni della prima adolescenza in maniera tutt’altro che felice. Bullizzata dai suoi coetanei e trattata come una bambola di porcellana dai genitori, ha finito per diventare una persona completamente priva di autostima e di fiducia in sé stessa. Il pensiero di essere condannata a vivere come una pietra per il resto della vita è cresciuto a tal punto da diventare una ferma credenza. L’unico in grado di scalfire questa monolitica certezza è Kei Miura, un ragazzo incontrato per caso che, con poche ma schiette parole di incoraggiamento, le permette di intravedere una via d’uscita dall’isolamento auto-imposto.
Ishimori decide di iscriversi allo stesso liceo del ragazzo e ciò le permette di creare, per la prima volta in vita sua, dei legami relazionali. Grazie a questi, riuscirà a conoscersi e a scoprire i suoi pregi e talenti. Imparerà a prendersi delle responsabilità e ad affrontare situazioni che prima la paralizzavano. Inoltre, sperimenterà per la prima volta l’innamoramento proprio nei confronti di Miura…
E qual è la novità?
Già solo leggendo in queste poche righe la trama di Honey Lemon Soda è facile capire che non si tratta di una storia particolarmente originale. Le dinamiche sono abbastanza classiche e in più occasioni mi sono venuti in mente sia Komi can’t communicate che Blue Box, ma sono sicura che chiedendo a qualcun altro, ci avrà trovato altri rimandi. Forse è per questo che il manga di Mayu Murata – iniziato nel 2015 e composto ad oggi da 27 volumi in Giappone – non è ancora arrivato in Italia.
Giudicare un manga o un anime per l’originalità sarebbe fuorviante. È un’industria che si basa sulla ripetizione di specifici elementi narrativi che si sa essere in grado di suscitare determinate emozioni in chi legge o guarda. Ovviamente non mancano i titoli rivoluzionari o visionari, ma si tratta di eccezioni, non della regola. Non è detto, però, che nelle narrazioni più tradizionali non si possa trovare l’elemento d’interesse che rende la visione unica e l’opera caratteristica. Nel caso di Honey Lemon Soda ce ne sono diversi su cui vale la pena soffermarsi.
Una protagonista che può farcela anche da sola
Uka Ishimori non è una protagonista facile da amare. Esattamente come Myo di Il mio matrimonio felice a primo impatto può risultare pesante per la sua insicurezza, per la fragilità emotiva e per i continui dubbi su sé stessa e sui propri comportamenti. Eppure, rinchiuderla in questa definizione significa non tener conto della sua storia né del processo di crescita che attraversa nel corso degli episodi.
Ishimori è un personaggio molto realistico. L’autostima non si costruisce in un giorno e, soprattutto, non si può basare solo su rassicurazioni esterne che arrivano una o due volte nella vita. Conoscersi e valorizzarsi è un processo lento e ricco di ricadute e tentennamenti. Si può avere difficoltà a riconoscersi in una protagonista simile, ma sarebbe scorretto non attribuirle una grande forza d’animo e una buona capacità di riscatto personale che possono essere fonte d’ispirazione.
L’amore come trampolino di lancio verso sé stessi
Un altro aspetto positivo di Uka da non sottovalutare è la sua voglia di farcela anche da sola. Nonostante il supporto di Kei sia fondamentale per iniziare a credere in sé stessa e per creare nuovi legami relazionali, Ishimori non vuole dipendere dal ragazzo che le piace né si aspetta di essere protetta da lui. Piuttosto, usa la fiducia che lui le ha dimostrato come incoraggiamento per superare gli ostacoli che le si presentano davanti.
Trovo sempre piacevole vedere rappresentate dinamiche simili in una storia perché possono essere illuminanti soprattutto per ragazze di giovane età (target principale dell’anime). A fronte delle tante storie in cui la donna deve aspettare l’arrivo del principe azzurro per essere salvata (presenti ancora oggi), trovarsi di fronte protagoniste in grado di percorrere la propria strada da sole è rigenerante. Ciò non comporta l’esclusione dell’amore romantico, ma ne dà una rappresentazione più sana. Il compagno diventa un alleato, non l’eroe della storia. E così dovrebbe essere anche nella vita di tutti i giorni. Le relazioni che intrecciamo – romantiche e non – sono fondamentali per crescere, per esperire, ma non possono essere determinanti né assolute.
Gelose o solidali?
Ricorderò con piacere Honey Lemon Soda anche per la profonda gentilezza alla base dei legami femminili presenti nella serie. Particolarmente interessante è il rapporto tra Uka e Serina, le due “rivali” in amore.
Siamo abituati/e a vedere il triangolo amoroso rappresentato come una vera e propria competizione: le due contendenti possono essere “sportive” tra loro, ma non sono di certo solidali. Devo ammettere che mi è già capitato di rimanere sorpresa di fronte alla maturità con cui molti personaggi di manga e anime accettano che il loro interesse amoroso sia innamorato di un altro o un’altra. Guardando Inuyasha, ad esempio, ero rimasta colpita da come Kagome si relaziona a Kyoko nonostante la sua giovane età e la paura di perdere la persona da lei amata.
In Honey Lemon Soda questo stesso tema prende una piega ancora più netta. Vediamo Uka e Serina sviluppare un vero e proprio legame di amicizia. Sono sincere l’una con l’altra, si supportano reciprocamente e sono pronte ad aiutarsi a vicenda. Con il loro rapporto ci dimostrano che i legami tra donne non dovrebbero essere condizionati dalla presenza dell’uomo, ma vanno vissuti per ciò che sono. Anche perché le scelte riguardanti i sentimenti sono sempre personali e sono determinate da molteplici e disparati fattori che, magari, non hanno nulla a che fare con la presenza di un’altra persona.
Spezzare i legami con i genitori… oppure no?
Il nono episodio della prima stagione – Addio, me impacciata – è quello che mi ha permesso di apprezzare più di tutti la serie. Si tratta della puntata in cui Uka deve affrontare il padre che si oppone agli amici eccentrici della figlia tanto da decidere di non mandarla più a scuola.
Lo scontro con i genitori è fondamentale in una storia adolescenziale. Se poi questi sono in parte responsabili delle difficoltà del/la protagonista, il confronto è d’obbligo. Cresciuta con un padre iperprotettivo, Uka non è mai riuscita a essere davvero sincera con i suoi genitori. Per non farli preoccupare, ma anche per non intaccare l’immagine idealizzata che loro avevano di lei, la ragazza non è mai stata in grado di confessare le angherie subite alle medie. La mancanza di comunicazione continua anche durante i primi mesi di scuola superiore fino a quando non si arriva al punto di rottura tra i due.
Lo dico senza troppi giri di parole: ho odiato il signor Ishimori. Le sue preoccupazioni per la figlia mi sono sembrate morbose e ho provato parecchio fastidio nel vederlo agire al posto di Uka. Pur essendo fatto tutto in nome dell’amore genitoriale, la cecità di lui di fronte ai desideri e ai bisogni della figlia è difficile da mandare giù.
Ancora una volta, però, sono rimasta sorpresa dalla risoluzione trovata dalla protagonista di Honey Lemon Soda. Guardando la bontà delle intenzioni e restando ferma sui suoi desideri, Uka riesce a trasformare il suo rapporto con il padre senza perderlo del tutto. Per la prima volta, confessa quello che ha dovuto subire e spiega le motivazioni che l’hanno spinta a nascondere tutto. Inoltre, esprime in maniera franca i suoi bisogni portando il genitore ad ascoltarla. In questo modo, può rivendicare la propria libertà di scelta senza rinnegare i suoi legami familiari.
Una risoluzione che può apparire poco realistica (questa sì), ma che comunque non è del tutto improbabile e che rimane bella da guardare.
Honey Lemon Soda: quello che non ho capito
Un episodio che ho avuto difficoltà a guardare, invece, è stato l’undicesimo (Emergete liberamente, miei sentimenti). La colpa è prevalentemente del montaggio. Le tante scene divise tra loro dall’immagine della strada che scorre in avanti mi hanno creato un effetto dissociante piuttosto che immersivo. Non ho ben capito la necessità di questo espediente visivo. Rappresenta il correre degli eventi? Il destino d’amore che sta per compiersi? L’accelerazione della narrazione? Non lo so. In ogni caso, è stato straniante.
Non ho particolarmente apprezzato neanche le inquadrature sovrapposte presenti in alcuni episodi. Gli slide show come se si stesse guardando una presentazione Canva non mi sembrano una trovata particolarmente riuscita dal punto di vista estetico. Potrebbe esserci la volontà di citare le tavole del manga… però stiamo sempre parlando di media diversi che sfruttano linguaggi diversi per la costruzione di un determinato significato. Per omaggiare il lavoro di Murata si potevano trovare tante altre alternative.
I disegni non mi dispiacciono anche se non ho amato particolarmente la scelta di rendere tutti gli occhi gialli. Va bene il richiamo alla limonata, ma c’era davvero bisogno di coinvolgere tutti i personaggi?
Al di là di queste perplessità, le animazioni funzionano e anche il ritmo della storia. I 12 episodi scivolano via velocemente e, una volta finiti, si avrebbe voglia di vedere ancora che cosa succede.
La seconda stagione di Honey Lemon Soda
L’anime ha una sua conclusione, ma il personaggio di Kei rimane alquanto misterioso. So che la prima stagione ha adattato solo i primi 8 volumi della serie e, quindi, non è difficile immaginare che ci sia ancora molto altro da dire e da raccontare. Sembra che la seconda stagione sia in produzione anche se è difficile credere che la vedremo prima del 2026. Con tutto quello che ho da leggere e da vedere, non credo che mi riuscirò a dedicare al manga… però non si sa mai nella vita.
Scheda tecnica
| Titolo originale: | Honey Lemon Soda ハニーレモンソーダ |
| Studio di animazione: | J.C.Staff e TMS Entertainment |
| Anno di uscita: | 2025 (dal 9 gennaio al 27 marzo) – 12 episodi |
| Manga: | 27 volumi già usciti, ma la serie è ancora in corso. La prima pubblicazione risale al 2015. Il manga è ancora inedito in Italia. |
| Genere: | shojo, romantico, scolastico |
| Voto: | 3/5 |
| Da guardare se: | si amano gli anime ambientati in ambiente scolastico o se si ha voglia di dolcezza. |
Federica Crisci
Le immagini contenute in questa recensione sono riprodotte in osservanza dell’articolo 70, comma 1, Legge 22 aprile 1941 n. 633 sulla Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio. Si tratta, infatti, di «riassunto, […] citazione o […] riproduzione di brani o di parti di opera […]» utilizzati «per uso di critica o di discussione», nonché per mere finalità illustrative e per fini non commerciali. La presenza in Anime a Merenda non costituisce «concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera».